
L’anamorfosi, dal greco
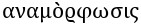
un neologismo del XVII secolo traducibile come “dare una nuova forma a una figura” oppure “realizzare una forma al contrario” [1], è un’immagine che, proiettata sul piano, risulta distorta e può essere resa riconoscibile solamente se osservata secondo certe condizioni (anamorfosi prospettica, ad esempio da un preciso punto di vista) o attraverso l’uso di strumenti deformanti (anamorfosi catottrica, che richiede l’uso di specchi cilindrici o conici). A partire dal Rinascimento diversi pittori ne hanno fatto uso e le anamorfosi sono spesso presenti nei Gabinetti di Fisica o nelle wunderkammer del diciottesimo secolo. Esse non sono di per sé strumenti scientifici, ma costituiscono divertenti (a volte maliziose) riproduzioni artistiche atte ad esemplificare la legge della riflessione dei raggi luminosi da parte di una superficie curva.
Nell’atto di donazione di Padre Mariano Morini all’Università di Modena del 1773 [2], riguardante una collezione di strumenti scientifici di proprietà personale del Morini, compare menzione di “Spechio cilindrico con sue carte n. 12” (ved. Fig. 1).

Presumibilmente alcune delle dodici carte di cui si fa menzione nel rogito sono parte delle anamorfosi cilindriche arrivate a noi. Lo specchio cilindrico che serviva per osservarle è andato perduto e nel rogito non vi è alcuna descrizione delle sue caratteristiche. Uno specchio cilindrico accompagnato da una collezione di tavole è citato (ved. Fig. 2) anche al n. 26 nel registro inventariale del R. Gabinetto di Fisica, 1813:
“Uno specchio cilindrico di metallo bianco. E’ formato di una grossa lamina di bronzo fuso lunga 0.18.8 larga in superficie m.tri 0.6 pesante 0,4,4, incurvata a modo di mezza superficie cilindrica e sostenuto da un fulcro di legno tinto in nero sul quale è ritenuta dal coperchietto di legno che si ferma con vite di ottone. E’ asortito di diversi disegni in proiezione circolare contenuti in una cartella di custodia nella quale è inscritto l’elenco de’ medesimi.”


Da questa descrizione la lamina di cui lo specchio (emicilindrico) era composto sembrerebbe avere dimensioni in larghezza 0.6 m, che farebbe pensare ad un cilindro molto più grande rispetto ad analoghi specchi cilindrici facenti parte di altre collezioni coeve e arrivati fino a noi [3,4]), mentre le unità di misura della lunghezza (0.18.8) non sono specificate. Anche l’unità di misura del peso dell’oggetto (0,4,4) non è specificata e nella notazione numerica viene usata la virgola al posto del punto.
Negli inventari a disposizione non sono stati finora riscontrati altri riferimenti diretti alle anamorfosi e allo/agli specchi cilindrici che venivano utilizzati per vederle nelle proporzioni usuali.
Uno specchio cilindrico con diametro di 6 cm e un’altezza di 26 cm (ved. Fig. 3 e [4]) facente parte del Gabinetto di Fisica fondato da Giovanni Poleni a Padova nel 1739 ci offre un esempio quasi coevo di come dovevano essere gli specchi cilindrici per osservare i nostri anamorfemi. Analogo specchio è in mostra presso il Museo Galileo di Firenze [3].

La legge della riflessione dell’ottica geometrica
Si chiama “ottica geometrica” quella branca dell’ottica in cui le proprietà della luce sono descritte attraverso lo studio dei cammini dei raggi luminosi. Le leggi dell’ottica geometrica sono applicabili quando la luce interagisce con oggetti grandi (rispetto alla sua lunghezza d’onda), come specchi e lenti. La legge della riflessione riguarda la previsione della direzione che un raggio luminoso prende dopo aver colpito una superficie, venendone in parte o del tutto respinto. Definiti “angolo di incidenza” e “angolo di riflessione”, rispettivamente, gli angoli formati dal raggio incidente e dal raggio riflesso con la direzione perpendicolare alla superficie riflettente nel punto di incidenza, allora: 1) l’angolo di incidenza è uguale all’angolo di riflessione e 2) raggio incidente, perpendicolare al punto di incidenza e raggio riflesso stanno sullo stesso piano. In Fig. 4 è esemplificata la legge della riflessione per il caso di uno specchio piano.

Anamorfosi nella storia dell’arte
Nelle arti figurative la prospettiva basata su calcoli geometrici per disegnare figure su una superficie piana in due dimensioni che riproducono fedelmente una scena tridimensionale raggiunge la sua maturità teorica e realizzativa all’inizio del 1550 con l’elaborazione del “De Pictura” (1511) di Leon Battista Alberti: l’osservatore in posizione frontale davanti al dipinto percepisce una rappresentazione coerente con l’osservazione tridimensionale della realtà nella profondità virtuale della scena rappresentata. Contemporaneamente allo sviluppo della prospettiva centrale, inizia a farsi strada un’altra tecnica secondo la quale un soggetto appare realistico solo se osservato da una prospettiva eccentrica. Questa tecnica, le cui prime sperimentazioni risalgono a Piero della Francesca e Leonardo da Vinci, verrà poi definita anamorfosi prospettica. Nelle anamorfosi prospettiche il disegno è intenzionalmente deformato e a prima vista il soggetto è confuso, indecifrabile. Lo stesso disegno, se osservato di scorcio, a una determinata distanza dal piano del disegno, si rivela nelle corrette proporzioni e sembra magicamente ‘emergere’ dal piano in cui è stato realizzato, assumendo caratteristiche tridimensionali [1].
Accanto alle anamorfosi prospettiche, ve ne sono altre, dette ‘catottriche’ che fanno uso di specchi curvi per rettificare la deformazione anamorfica: in altre parole, la distorsione è realizzata in modo da restituire le proporzioni corrette del disegno osservando l’anamorfosi indirettamente, non già sulla superficie su cui è tracciata, dove appare deformata da qualunque punto di vista, ma tramite la riflessione da uno specchio curvo, di solito un cilindro o un cono metallico lavorato a specchio. L’aberrazione ottica del riflesso compensa la deformazione del disegno anamorfico e lo rende proporzionato e riconoscibile [1].
Questa tecnica, già praticata in Oriente, appare in Europa tra il 1620 e il 1630 e tratta inizialmente l’anamorfosi come una curiosità, un’appendice matematica della prospettiva, finché nel 1638 il giovane frate dei Minimi Jean François Niceron scrive un trattato quasi interamente dedicato alle anamorfosi, chiamate dall’autore perspective curieuse [6]. Niceron spiega così cosa sia l’anamorfosi:
“…Prospettiva curiosa o magia artificiale degli effetti meravigliosi dell’ottica della catottrica e della diottrica. Nella quale, oltre a un compendio dei metodi generali della prospettiva comune, esemplificata sui cinque solidi regolari, si insegna come costruire ogni specie di figure deformi, che, viste da un punto adatto, appaiono ben proporzionate. Tutto questo con procedimenti così semplici che anche i meno esperti in Geometria potranno servirsene aiutandosi solo con riga e compasso. Opera utilissima a Pittori, Architetti, Incisori, Scultori, e a tutti coloro che si servono di disegni nel loro lavoro.”

Un esempio di anamorfosi cilindrica dell’epoca è mostrato in Fig. 5, che mostra una illustrazione tratta dall’opera Apiaria di Mario Bettini (1645) [7]. Grazie alla completezza, approccio didattico e dovizia di particolari, i trattati di Niceron diventano i testi di riferimento fino ai giorni nostri per gli artisti interessati alle anamorfosi, termine coniato dal gesuita Athanasius Kircher in un trattato pubblicato nel 1646, anno della morte prematura di Niceron.
Fra Mariano Morini e la nascita del Gabinetto di Fisica di Modena
Fra Mariano Morini [8], parmense (1732-1801), dell’ordine dei Minimi, fin dal 1760, si dedica a Modena all’insegnamento di vari rami della Filosofia Naturale, comprendente anche lo studio sperimentale dei fenomeni naturali. Fa esperienze sulla luce, progetta strumenti per lo studio dei terremoti, per la misura della pioggia, orologi. Ha così inizio, come avviene in altre città europee, la formazione di un Museo Fisico composto [8] “se non di poche e grossolane macchine in legno, e disposto era insiem colla scuola in una bassa stanza dell’attiguo Collegio de’nobili ” (ora Fondazione Collegio S. Carlo), uno dei primi in Italia. Nel 1772 il duca Francesco III d’Este decide di riformare ed ampliare lo Studio modenese per meglio attendere alla formazione specialistica dei futuri dirigenti dello stato. Fino a quella data, l’insegnamento della Fisica è compreso in una sola cattedra di istruzione filosofica, senza distinzione tra Fisica generale o sperimentale o particolare ma, con la riforma, una cattedra di Fisica Sperimentale viene separata dal resto ed affidata a Padre Domenico Troili della Compagnia di Gesù, mentre Padre Morini continua ad insegnare la Fisica generale. Con la riforma dello Studio modenese, il Teatro ed il Gabinetto fisico traslocano: la collezione di strumenti è trasferita nel nuovo Palazzo dell’Università “occupando il piano nobile ad occidente, riservata la parte orientale ad uso biblioteca”. Alla fine del 1773, Padre Troili rinuncia al pubblico incarico, così che con l’inizio del 1774 l’insegnamento della Fisica Sperimentale passa a Padre Morini che lo tiene fino al 1786 quando diventa Provinciale del suo ordine religioso. Al suo posto è nominato il famoso abate Giovanni Battista Venturi da Reggio Emilia. Validi collaboratori del Gabinetto fisico sono i macchinisti: coloro che, in un teatro o un gabinetto di fisica, erano responsabili della collezione di strumenti, effettuavano le necessarie riparazioni e spesso ne costruivano di nuovi. Sono passati alla storia dello sviluppo scientifico a Modena fra’ Modesto Olivieri da Ligorzano (Modena) che lavora nell’Ateneo fino al 1774, fra’ Fedele Minari da Scandiano (Reggio Emilia) che è inviato a Pavia e un altro religioso, il Cappuccino frate Agostino Arleri da Vinchio (Asti) che lavora dal 1774 fino al 1820 circa (queste informazioni sono tratte da un appunto anonimo ritrovato presso il Dipartimento di Scienze Fisiche, Informatiche e Matematiche fra vecchie carte ed antichi inventari a Settembre 2023).
Il Collegio dei Nobili di San Carlo di Modena
Antica istituzione [9] nata a Modena ai primi del Seicento dall’impulso di una Congregazione di laici devoti, “umili artieri”, guidata dal sacerdote Paolo Boschetti con l’intento di fornire la necessaria cultura di governo al ceto nobiliare. Nel 1626 l’Istituzione diviene Collegio dei Nobili di San Carlo, aperto ai figli delle famiglie nobiliari italiane e di altri paesi europei, secondo un modello educativo che colloca gli studi scientifici e giuridici accanto a quelli teologici, letterari e filosofici. Grazie anche alle risorse reperite dal Boschetti e a cospicui lasciti, lo sviluppo del Collegio è rapidissimo: nel 1662 riprende le letture universitarie dell’antico Studium modenese che diviene Studio Pubblico in San Carlo; nel 1685 lo Studio diviene Università con piena facoltà di addottorare.
Per quasi un secolo il Collegio coincide con l’Università finché, nel 1772, il duca Francesco III separa le due realtà: le lezioni universitarie escono dal Collegio, insieme alle consistenti dotazioni librarie, per andare a costituire l’Università del Ducato. Il Collegio conserva, quindi, solo le scuole basse e il suo raggio d’azione si restringe. Nella tarda estate del 1797, con l’arrivo dei francesi, il Collegio è travolto dall’ondata giacobina e diviene in rapida successione Collegio Civico, poi Collegio Municipale con la Repubblica Cisalpina e infine Collegio Nazionale con il napoleonico Regno d’Italia. Soppressa la Congregazione, nel 1805 la direzione del Collegio viene affidata al Rettore e a due cittadini nominati dal Governo. Viene così inaugurato il sistema di conduzione che sarebbe rimasto immutato, pur nei cambiamenti di regime e di Enti di nomina, fino a tempi recenti. Nonostante il ritorno dei Duchi, è ormai superata l’idea di cultura che aveva retto il Collegio dei Nobili: nell’Ottocento le porte vengono aperte ai figli della borghesia e calano nella prassi pedagogica le nuove idee che rivendicano per un altro ceto la funzione di riferimento e di guida. Così il Collegio assume preminenti finalità di istruzione che si accentuano, con la transizione al Regno d’Italia, quando le Scuole del Collegio divengono parificate e recepiscono i programmi governativi, pubblici e laici. Nel 1954, dopo gli anni difficili della guerra e della ricostruzione, il Collegio cambia la propria natura giuridica, diventando una Fondazione di diritto privato. Prende così avvio una nuova fase che, nei decenni successivi, conduce alla riconversione del San Carlo da Istituto di istruzione a Fondazione culturale, con un autonomo progetto di attività.
Si ringraziano il Dott. Maurizio. Salvarani e la Dott.ssa Lia Apparuti del Museo della Bilancia di Campogalliano per la consulenza relativa all’interpretazione delle misure contenute nella descrizione dello specchio cilindrico e la Prof.ssa Morelli per le informazioni inventariali.
Bibliografia
[1] P. Di Lazzaro e D. Murra, P. Vitelli: “Immagini anamorfiche in un viaggio interdisciplinare tra arte, storia, geometria e attualità” ENEA ISBN: 978-88-8286-376-0 (2019) https://www.researchgate.net/publication/330798158
[2] Archivio di Stato Modena, Archivio Notarile, Rogiti Luigi Reggiani, a. 1773, n.5482
[3] Catalogo del Museo Galileo di Firenze https://catalogo.museogalileo.it/oggetto/Anamorfosi.html
[4] https://www.museionline.info/musei/museo-di-storia-della-fisica-padova
[5] Immagine tratta da https://www.latteseditori.it/images/luce.pdf
[6] J.F. Niceron, La Perspective Curieuse, ou Magie Artificiele des Effets Merveilleux, Paris, Chez Pierre Billaine,1638.
[7] Illustrazione tratta da I Gabinetti di Ottica – Tra leggi fisiche e visioni dell’immaginario, a cura di Giorgio Celli, Edizioni Artificio (1992).
[8] Giuseppe Bianchi, Il Museo e Teatro Fisico in: Alla memoria di Francesco IV Articoli tre Accademici, Modena Eredi Soliani, (1846), pag. 37, Estratto dal tributo della Reale Accademia di Scienze, Lettere ed Arti di Modena alla memoria di Francesco IV.
[9] https://www.fondazionesancarlo.it/fondazione/fondazione/storia/
Autore: Prof.ssa Rossella Brunetti, Dipartimento di Scienze Fisiche, Informatiche e Matematiche
